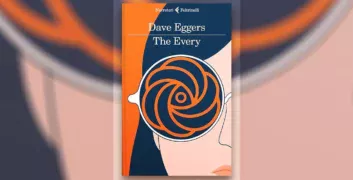“Dovrebbe smettere”.
Lo si sente dire spesso, a proposito di grandi band arrivate oltre soglie fatidiche, che siano tanti anni di carriera o all’anagrafe.
Così tanti da diventare troppi.
L’ho sentito dire anche per i Bon Jovi, alla soglia di 36 anni dal primo album, migliaia di live alle spalle, il loro leader Jon ormai 58enne come il tastierista David Bryan, mentre già verso i 70 veleggia il batterista Tico Torres altro unico elemento rimasto della line-up originale.
Dopo il periodo hard rock melodico e gli album milionari (Slippery When Wet e New Jersey), dopo essere riusciti a sopravvivere alla bufera grunge con il rock più puramente americano (Keep The faith), dopo essersi reinventati con un disco più autoriale (These days), dopo gli anni 2000 dove il solo Have a nice day è riuscito a spiccare, ma ancora tanti hit singoli hanno solcato le classifiche (It’s my life, We weren’t born to follow, Who says you can’t go home), la domanda che possa bastare tutto questo per chiudere in bellezza ed evitare un lento declino, magari virando su altri progetti, è legittima.
Una domanda acuita da alcune esibizioni live in cui Jon da tempo appare molto giù di voce circondato da una band spompa, complice anche la ormai consolidata (irrecuperabile?) assenza del chitarrista Richie Sambora, anima e cuore elettrico della band, fuoriclasse perduto dietro progetti discutibili e non troppo presunte dipendenze. Il suo rimpiazzo Phil X, del resto, non ha mai scaldato i cuori e le orecchie dei fan.
Per questi motivi temevo molto “2020” e, al primo ascolto, la preoccupazione si rivela fondata.
Il singolo “Limitless” è insulso, dovrebbe essere tirato, suona fiacco. Anche “Do what you can” marcetta ottimistica incentrata sul momento della pandemia, idem. (Si salva nella versione bonus giapponese, in duetto con Jennifer Nettles degli Sugarland che sostiene le carenze vocali del nostro e alza il brio).
“Let it rain” parte bene nella strofa, bomba che si carica ma non esplode mai e la pessima “Beautiful Drug” evoca moderni U2, però mal riusciti. Anche “Brothers in arms” potrebbe essere uno scarto di Keep the faith.
Dove serve energia è chiaro che le riserve sono quasi esaurite.
Però.
Però Jon e i suoi scelgono, nei pezzi più lenti, una virata nettamente “impegnata”, usandola per raccontare il mondo in subbuglio del 2020.
Come ho letto in una recensione migliore dalla mia, Jon non è più il rocker cotonato wild in the streets che fa impazzire le ragazzine né il fascinoso e atletico quarantenne con la zazzera a ciuffo che grida “questa è la mia vita, adesso o mai più”. Somiglia a un padre imbiancato che osserva il mondo fuori, racconta lo scuotersi violento di un’America in cui ha avuto lui, ragazzo bianco e bello del New Jersey, ha avuto la tenacia e la fortuna di realizzare il suo personale sogno.
In “American Reckoning” un Jon molto più roco del solito affronta il caso Floyd e sussurra “ I can’t breathe” (doveva essere il titolo del pezzo, ma la band non era convinta della scelta).
“Da quando un giudice e una giuria sono diventati un distintivo e un ginocchio, su queste strade?
“Lower the flag” è dedicata alle conseguenze delle diffusione delle armi, con i nomi delle scuole teatro di tragedie ripetuti in coro nel finale. “Unbroken” è un inno patriottico solo a metà alla maniera di Springsteen, sui reduci traumatizzati dalla guerra, sul senso di cosa si riporta a casa servendo il proprio paese tra dolore, onore, orrore.
La ballatona “Blood in the water” si piazza a metà tra “Dry county” e “Always” ma parla di fake news e disinformazione, riuscendo nell’impresa di far piazzare un assolo degno di memoria (lo suona John Shanks, produttore del disco e non l’usualmente fantasmatico chitarrista Phil X il cui ruolo nella band mi appare ancora misterioso come il suo soprannome)
Quando gli hanno chiesto se non temesse le reazioni delle fetta di pubblico conservatore alla svolta politica di questo album, il cantante leader della band ha risposto: “Che posso fare? Editarmi in modo da essere fuori solo per promuovere una canzone? Se lo facessi, a questo punto della carriera, chi sarei? Era più importante per me fare un disco che avesse qualcosa da dire che riscrivere “bad name” 36 anni dopo”E questi pezzi hanno qualcosa da dire, ancora, anzi mi fanno auspicare una svolta definita in questa direzione, dove si mettono da parte gli woooh-wooahhh per gli yeah, dove la zazzera è diventata grigia sotto il cappello da cowboy, dove la rockstar diventa storyteller e noi siamo ancora disposti a dargli fiducia anche se non sono più fuochi d’artificio, ma un falò per illuminare il buio che ci circonda troppo spesso.
Non smettete.