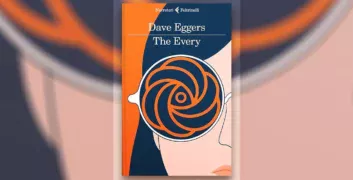C’è un uomo italiano che non ho timore a chiamare eroe, la cui vicenda pochissimi conoscono, nonostante risalga a pochi anni fa, al 1994.
Forse perché tutto accade lontano da noi.
Così lontano che il nostro mondo nemmeno si accorge di cosa sta accadendo in Ruanda, dove si verifica un genocidio unico e forse mai superato per la sua rapidità, brutalità ed efficacia, con numeri che a pronunciarli fanno spavento: un milione di morti in cento giorni.
Uomini e donne, giovani e anziani, massacrati in uno dei più cruenti e vergognosi episodi che la storia dell’uomo possa conoscere e persino immaginare.
L’odio che si scatena tra gli Hutu e i Tutsi è, in realtà, privo di un reale motivo etnico. Le due etnie – come la terza, di gran lunga minoritaria, degli Twa – parlano la stessa lingua, praticano la stessa religione e hanno convissuto per secoli in Ruanda.
Il solco è stato scavato dal colonialismo belga che si appoggia in un primo momento all’etnia Tutsi dall’aspetto più “occidentale”, più alti, con lineamenti fini, più chiari di pelle per emarginare gli Hutu. Poi, però, i coloni scelgono di cambiare versante, premiando gli Hutu, molto più numerosi, e penalizzando i Tutsi.
I Belgi codificano la differenza anche sui documenti d’identità.
Partendo da una differenza razziale inesistente i coloni riescono a creare una divisione reale fra le etnie.
Lo scontro fra etnie cresce ed esplode in violenze, arrivando a una guerra civile tra il 1990 e il 1993 e restando irrisolto.
In questo clima figlio di anni di odio la tragedia esplode alle 20,21 del 6 aprile 1994, quando l’aereo Falcon a bordo del quale vola il presidente Habyarimana, sostenuto anche dagli Hutu più estremisti, viene colpito da due missili e abbattuto. Muoiono tutti i passeggeri.
Dell’attentato vengono immediatamente accusati i Tutsi: la radio Mille Collines lancia l’appello a sterminare «gli scarafaggi tutsi» e nelle strade della capitale Kigali vengono creati posti di blocco per un massacro indiscriminato.
Non si tratta nemmeno più di una guerra, ma di persone armate che uccidono civili per lo più inermi solo in base alla loro presunta appartenenza etnica: se sulla carta di identità hai scritto “Tutsi”, sei morto. Se sei alto, se hai la pelle più chiara, il naso più sottile, se – insomma – anche solo a guardarti sembri un Tutsi, sei morto ugualmente.
Lo stesso accade con la piccola etnia Twa.
L’attacco degli Hutu estremisti colpisce anche i politici hutu moderati che rifiutano la superiorità etnica. La premier donna Agathe Uwilingiyimana viene violentata e uccisa. I caschi blu belgi che dovrebbero difenderla sono neutralizzati. Dieci di loro vengono fatti prigionieri, portati in un campo militare e uccisi.
Il Belgio e l’Occidente, ritirano i caschi blu, lasciando in Ruanda pochissimi uomini del tutto impossibilitati a intervenire.
Il mondo rimane a guardare un massacro senza precedenti a colpi di machete, coltelli, mazze.
Nel giro di cento giorni in Ruanda, una terra grande quanto il nostro Piemonte, vengono uccise un numero vicino al milione di persone e duecentocinquantamila donne vengono stuprate.
Nel disastro molti turisti e gli stranieri che lavorano in Ruanda sono già evacuati da tempo, ma qualcuno no, è rimasto.
Uno di loro è un uomo italiano.
Si tratta del console onorario Pierantonio Costa, imprenditore nativo di Mestre, che in quel momento ha 55 anni e si è trasferito a vivere e lavorare con successo nel Ruanda che ama, dove ha conosciuto e sposato Mariann, una cittadina svizzera da cui ha avuto tre figli.
«Quello che stava accadendo era al di là di ogni immaginazione. Osservavo quella barbarie pensando che millenni di civilizzazione e di convivenza erano solo un sottile strato di vernice sulla capacità dell’uomo di commettere atrocità, e di godere della sofferenza inflitta.»
Una bestialità con cui il 16 aprile a Murambi circa sessantacinquemila Tutsi fra uomini, donne, bambini vengono stivati in una scuola, indifesi. L’edificio è attaccato dai paramilitari e le persone dentro si difendono usando le pietre. Ma quando arrivano rinforzi armati, il massacro si compie. Si salvano solo trentaquattro persone, ritenute morte per errore.
Il console Pierantonio Costa non può restare inerte di fronte a questo scempio.
«Ho solo risposto alla voce della mia coscienza. Quando bisogna fare qualcosa, semplicemente lo si fa.»
Nel momento in cui scoppia la follia, Costa è in casa, con la famiglia. Gli arrivano notizie di amici italiani chiusi in casa e anche di tanti amici ruandesi e di etnia tutsi che temono per la propria vita o sono già morti.


Una delle prime cose che fa, con la moglie, è cucire a mano alcune bandiere italiane con stoffe di fortuna e farle esporre all’esterno delle case in cui abitano persone che ritiene in pericolo.
È un modo per far desistere chi volesse assaltarle.
Ma la situazione nelle strade è troppo pericolosa, cercare di aiutare qualcuno in Ruanda è quasi impossibile; allora Costa va a sistemarsi nella proprietà terriera del fratello nel vicino e più sicuro Burundi, poi inizia a fare la spola dentro e fuori dal confine ruandese.
Con l’aiuto del figlio Olivier e di alcune ONG, sfruttando il suo ruolo politico e i propri fondi economici personali, dai quali attingerà un totale di oltre 3 milioni di dollari, facendo leva su contatti e amicizie maturati negli anni, Costa inizia a trasportare fuori dal Ruanda, per sottrarle al macello, quante più persone riesce sulla sua jeep o mettendo insieme convogli umanitari. Per superare i controlli attacca alla macchina quei tricolori che per molti disperati divengono emblema dell’unica salvezza possibile.
Decisi che avrei operato così. Mi sarei vestito sempre allo stesso modo per essere riconoscibile: pantaloni scuri, camicia azzurra, giacca grigia. Distribuite nelle tasche – e sempre nello stesso posto – avrei messo banconote da cinquemila franchi ruandesi (circa venti euro), da mille, da cinquecento e, infine, da cento franchi, per essere sempre pronto a estrarre la cifra giusta, senza dover contare i soldi: la mancia dev’essere data nella misura giusta, se dai troppo ti ammazzano per derubarti, se dai troppo poco non passi. Nella borsa avrei avuto costantemente con me alcuni fogli con la carta intestata del consolato d’Italia, e sul fuoristrada ci sarebbero state le immancabili bandiere italiane.
Quanto alla durata delle incursioni oltre confine, avrei evitato il più possibile di dormire in Ruanda e di viaggiare col buio.
Il 23 aprile 1994 inizia la sua operazione con un convoglio di una cinquantina di persone: tra loro, insieme agli ultimi italiani rimasti che Costa ha recuperato, ci sono anche alcuni ruandesi.
Il 4 maggio porta via i figli di un colonnello locale, ma in cambio riceve una scorta armata e riesce a ottenere permessi per altre 31 persone: quando gli viene chiesto un favore da qualcuno di ancora influente, lui accetta, ma chiede in cambio altri favori per salvare persone, spesso del tutto sconosciute.
Su una strada di Kigali trova un ragazzo ruandese che vuole inserirsi con la sua macchina in un convoglio protetto da soldati europei, ma non ha abbastanza benzina. Costa va a farsi dare una tanica da un amico e gliela porta. «Tanto a te la benzina non serve più» dice all’amico.
Quando ritroverà quel ragazzo lui gli dirà che con la macchina ha portato via la sua famiglia: «Hai salvato cinque persone con venti litri di carburante».
Costa riesce ad aiutare i dipendenti della ditta italiana Astaldi e quelli delle proprie imprese, 40 impiegati in un negozio di pneumatici, 30 in un altro, 3 suore, un lavoratore che lui stesso aveva licenziato e tanti, tanti altri, mentre in Ruanda l’orrore impazza, la radio Milles Collines incita a «riempire le fosse, finire il lavoro». Purtroppo, gli assassini nelle strade si impegnano per riuscirci: nella sola capitale Kigali su trecentomila abitanti settantamila vengono massacrati.
«Di fronte a quell’apocalisse mi afferrai a quei pochi brandelli di bene, al dare una mano al missionario, al carico di viveri da portare in un orfanotrofio, a un amico che potevo aiutare.»
Con le sue manovre Pierantonio Costa salva quasi duemila persone.
Deve fermarsi quando l’ultima volta che tenta il passaggio del confine gli dicono che non potrà più rientrare in Ruanda o sarà ammazzato.
Gli ultimi salvati sono trecentosettantacinque bambini di un orfanotrofio della Croce Rossa.
Soltanto il 23 giugno del 1994 l’arrivo di soldati francesi pone un freno al disastro prima della fine vera e propria della guerra, dichiarata il 17 luglio 1994: il Fronte Patriottico Ruandese, non senza altre violenze e brutalità, riprende il possesso del paese e inizia l’esodo degli Hutu, sia gli autori del genocidio sia i civili stremati dalle malattie.
Dopo il massacro, nel 1994, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha stabilito la creazione del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, un organo speciale per giudicare i responsabili del genocidio.
Il tribunale ha lavorato per oltre vent’anni, fino alla chiusura nel 2016, emettendo sessantuno condanne per genocidio, diverse delle quali all’ergastolo. Le condanne hanno colpito rappresentanti politici, capi militari ed esecutori materiali delle violenza, ma anche rappresentanti dei media che incitavano all’odio e al massacro etnico, compresi fondatori e speaker della radio Milles Colines.
Il governo di unità nazionale del Ruanda, guidato dal presidente Paul Kagame, negli ultimi anni è riuscito, non senza ombre autoritarie, a trasformare il Ruanda in uno degli Stati a più forte e rapida evoluzione del continente africano.
Rimane il ricordo dell’orrore e dei pochi esseri che restarono umani, come il console italiano Pierantonio Costa.
«Non l’ho fatto cercando il martirio, non l’ho fatto cercando l’eroismo. Ho fatto il mio dovere come console e poi verso me stesso, verso la mia coscienza.»
La sua opera gli varrà una Medaglia d’Oro al Valor Civile in Italia, un analogo riconoscimento in Belgio, e la menzione nei Giardini dei Giusti di Padova e Milano.
«Tra tanta violenza e tante sofferenze ho solo fatto quello che dovevo fare. È tutto.»
___
La storia di Thomas Sankara, in forma più estesa, è inclusa nel mio libro “Come fiori che rompono l’asfalto – Venti storie di coraggio” (Rizzoli, 2020).
Il libro è reperibile in qualsiasi libreria fisica e sui principali store on line.