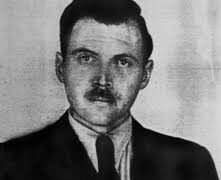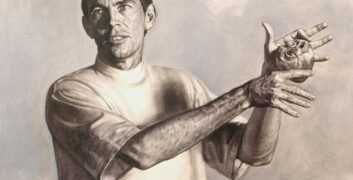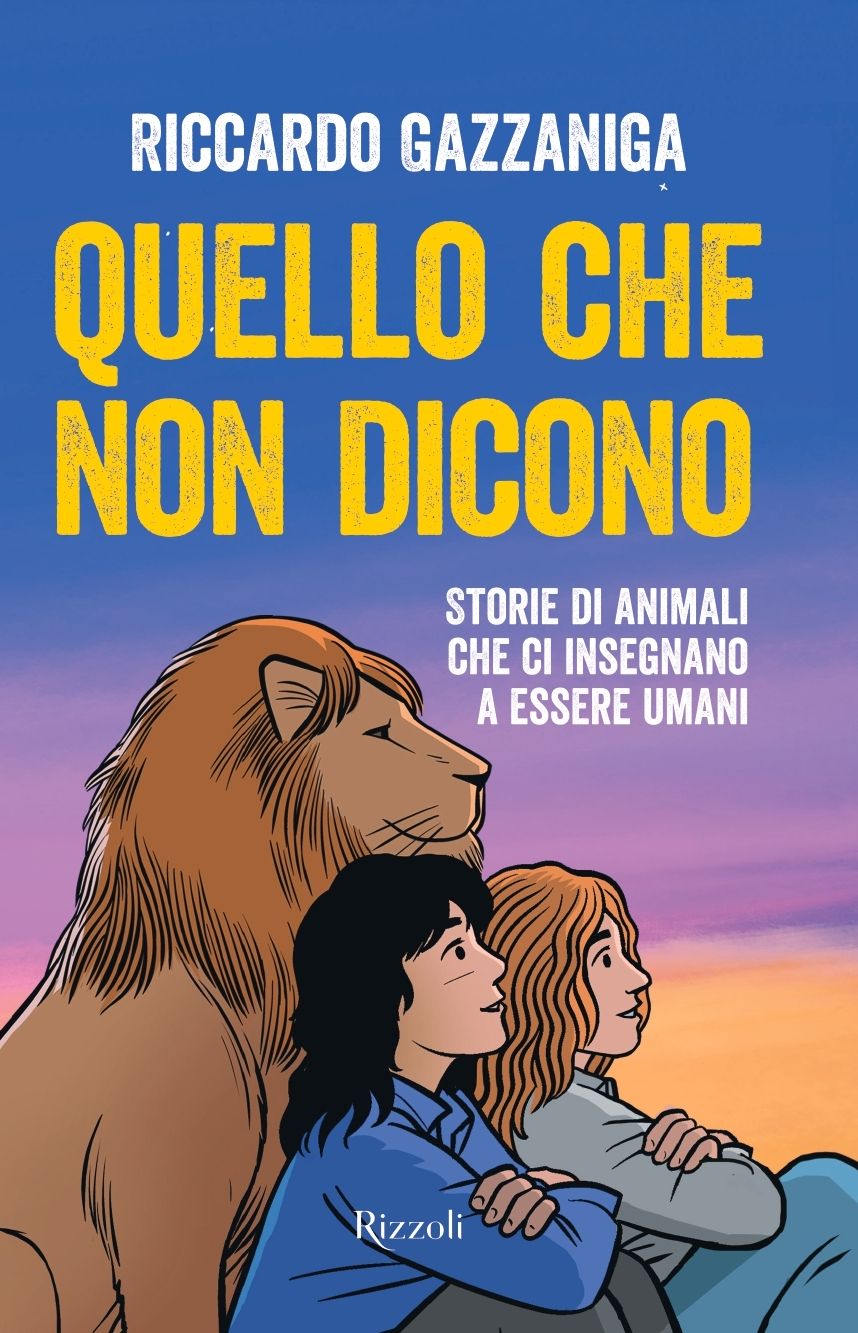Per parlare di ACAB devo sdoppiarmi: da una parte c’è Riccardo, scrittore di romanzi e libri per ragazzi, appassionato di cinema e serie e autore anche di una sceneggiatura per un film mai uscito; dall’altra l’ispettore Gazzaniga, con 29 anni di esperienza in Polizia, di cui 24 al Reparto Mobile.
Conosco bene, quindi, sia il mestiere di chi racconta storie che quello del “celerino” con le loro rispettive conseguenze e difficoltà.
Premessa: queste di seguito sono opinioni personali, per questo le posterò e condividerò solo sui miei canali. Non chiedetemi interviste, dichiarazioni e non generalizzate queste, sono mie e basta.
Premessa due: c’è qualche spoiler, nel testo che segue.
Bene, ora veniamo ad ACAB.
La vicenda prende le mosse da un gruppo di poliziotti che finisce implicato in un fatto di servizio molto delicato (il ferimento grave di un manifestante durante una carica) e per il quale nega la responsabilità pur evidente.
Ma il “fatto” entra nella lente della magistratura e questo va a minare sia i rapporti fra colleghi che le vite dei singoli peraltro già (molto) gravemente problematiche.
Lo spunto non è poi così innovativo (un casino/reato commesso in gruppo e che va coperto) come non sono nuovi le sottotrame e i temi che vi si innestano: l’intrecciarsi con vicende personali, la logica di gruppo e di omertà, lo scricchiolare dei rapporti fra colleghi di fronte all’aggravarsi del guaio, la possibilità di farsi giustizia da sé rispetto a un torto sfruttando il proprio ruolo lavorativo.
Niente che non abbiamo già visto in serialità americane ma molto meno facile da incontrare in Italia, dove la rappresentazione delle forze dell’ordine è sempre stata edulcorata, a volte noiosa altre stucchevole; qui di certo non lo è(dopo entrerò nel dettaglio).
La vera novità della serie è che cala il plot narrativo in un contesto quasi mai raccontato ovvero quello dei Reparti Mobili (15, in Italia) uffici che hanno precipue mansioni di ordine pubblico e che lavorano per “squadre” da dieci persone.
La narrazione poi non si limita alla trama, ma la mette in relazione con i temi dell’uso della forza, l’esigenza di sicurezza e ordine pubblico nella società, la responsabilità penale, il contesto storico e politico (non a caso la serie quasi “dimentica” che una massiccia parte dell’impiego dei Reparti Mobili, peraltro quella dove più facilmente scaturiscono problemi, è connessa al calcio e concentra il focus su aspetti politico-sociali).
L’azione operativa in ACAB avviene sempre in contesti di massa che hanno ottima resa televisiva ed emotiva, coinvolgono; le scene di azione sono efficaci e funzionano, hanno momenti forti (la visiera che scende, gli scudi che si schierano, la massa ostile sempre senza volto come viene percepita dai poliziotti) per quanto in alcuni casi siano macroscopicamente non credibili.
(Faccio tre esempi.
Uno: negli scontri con i tifosi inglesi la squadra rimane ferma mentre gli hooligans assaltano una macchina di servizio: impossibile, al primo calcio si sarebbero mossi.
Due: nella scena finale i 4 fuggiaschi con addosso il peso consistente di caschi e divise sfuggono a una massa di ragazzi in felpe e scarpe che li insegue: impossibile, fisicamente, sarebbero stati presi dopo dieci metri.
Tre: nei Reparti Mobili non si lavora mai per squadre fisse, il personale ruota sempre).
Però una serie non è mica un documentario e sarebbe ottuso non capire che certe forzature sono necessarie per un prodotto che deve funzionare su schermo.
Visivamente, ACAB si muove tra penombra e quasi totale oscurità, è una serie senza luce, riflesso del mondo interiore dei personaggi, con un tono noir raro per un prodotto poliziesco italiano.
A volte questa cupezza è talmente insistita da diventare “troppo” specie sommata ad alcune recitazioni: i personaggi dell’Ispettore Fura e dell’agente Lovato sfiorano la caricatura, anche quello del magistrato inquirente ha dei tratti un po’ monolitici.
Come tutti gli spettatori ho notato i problemi di audio: la voce di Giallini in particolare è un rantolo, spesso, e non mi è chiaro se sia dipeso dalle sue corde vocali o se l’audio (in generale difficile) della serie abbia peggiorato le cose.
Il finale di serie, pur con l’inverosimiglianza dell’ultima scena, è potente, epico, efficace.
ACAB funziona anche narrativamente, perché – come deve fare una buona narrazione – mette tutti i personaggi in mezzo a forti contrasti, conflitti, delusioni, dilemmi sulle scelte e gli errori.
Ma qui iniziano i problemi più profondi della serie e il motivo per cui la mia parte di poliziotto sente di bocciarla.
La scelta di raccontare una parte per il tutto (ovvero una sola squadra di Reparto Mobile e sempre, solo quella) è certamente necessaria e funzionale al prodotto, ma diventa un grosso problema nel momento in cui, dentro quella squadra, gli autori concentrano un’accolita di personaggi estremi, sull’orlo dell’esaurimento, marginalizzati, abusanti o abusati, in alcuni casi con non troppo velati tratti psichiatrici.
Mostrando SOLO una tipologia di poliziotto gravemente problematico è inevitabile fare l’equazione “celerino” = soggetto disagiato/pericoloso.
La motivazione iniziale (il ferimento di un collega che scatena la reazione degli altri) e qualche allusione vaga (l’ispettore Nobili dovrebbe raddrizzare i colleghi) non basta a inquadrare chiaramente questo gruppo e a spiegare la massa di comportamenti che definire sopra le righe è poco.
I poliziotti in scena, infatti, sono una sorta di associazione a delinquere che commette un’ampia sfilza di reati, alcuni premeditati, che culminano con la scena del sequestro con torture del ragazzino stupratore, una scena che è davvero eccessiva e forzata anche in quanto assurda narrativamente. Pur tralasciando il giudizio morale, infatti, quale persona con un briciolo di senso e di esperienza legale andrebbe a pensare una roba simile compiendo un reato macroscopico e gravissimo contro una persona appena denunciata e, per giunta, essendo già nell’occhio di un ciclone giudiziario?
Il problema è che a far da contraltare a questi eccessi manca qualsiasi compensazione.
I poliziotti rappresentati sono TUTTI compressi nel loro mondo distorto, TUTTI collusi in reati, TUTTI persone negative e sconnesse dalla società, dal mondo, dal loro ruolo istituzionale.
Se cercate un personaggio positivo, normale, non violento, non squilibrato, non estremo, beh, non c’è.
Non troverete nemmeno un personaggetto secondario che condensi l’enorme massa di poliziotti e poliziotte che fanno il loro lavoro di ordine pubblico nel quotidiano con scrupolo, onestà, normalità, nella routine del servizio, affrontando i problemi personali senza gesti eclatanti, intrecciando la vita e gli affetti con il loro lavoro che ne è una parte, ma non per forza ne è l’unico aspetto.
Mi spiace deludere chi pensa che dietro le divise del Reparto Mobile ci siano solo cuori e vite di tenebra: non è così.
La scelta tecnica del buio, dunque, diventa strumentale a rappresentare un universo di sola oscurità, isolamento, chiusura.
ACAB pare voler compiacere un immaginario, estetico e umano, sui “celerini cattivi”, ma è un immaginario che poteva forse andare (molto, molto) vagamente bene per gli anni Ottanta e Novanta in alcuni specifici Reparti Mobili, uffici che erano considerati “punitivi”.
Da allora tante cose sono cambiate, passando anche per il dramma del G8, per la nascita di un centro di ordine pubblico nazionale, per l’impatto dei telefonini e della mediaticità degli eventi che riguardano la piazza, per i ricambi generazionali che vedono gli stessi colleghi essere nativi digitali.
I Reparti Mobili sono diventati per varie ragioni uffici ambiti, in cui sono arrivati poliziotti con tante esperienze diverse, cambiandoli radicalmente da tanti punti di vista.
Ma Acab non sembra avere il tempo di ragionarci, perché è più comodo narrativamente, esteticamente, a livello promozionale e forse anche ideologico, attaccarsi a quell’immaginario desueto che era già stato fulcro del film e non mollarlo neppure un secondo.
La litania della canzoncina sul furgone “Celerino figlio di puttana” che gli agenti si cantano da solo quasi per caricarsi (scena ripresa dal film) è emblematica di questo spirito totalizzante.
Nel mondo-ACAB non esiste spazio per una battuta, un momento di normalità, leggerezza, persino gli alloggi dei colleghi sembrano celle di carcere, persino la festa di Natale diventa un emblema di solitudine e abbruttimento.
Parlare delle ombre sarebbe stato interessante, mettere solo buio diventa pretestuoso.
È innegabile che una serie che si intitola “ACAB”, che esce con la forza promozionale di Netflix e di un cast importante, che affronta un argomento delicato in un momento storico ancora più delicato, abbia un impatto anche etico e sociale.
Non dico che questo dovesse spingere gli autori a censurarsi, assolutamente, l’arte è sempre libera! Però almeno a farsi una domanda: “visto che do un respiro anche “sociale” alla serie, sto anche dando uno spaccato credibile e onesto del mondo che racconto e dei suoi appartenenti?”
E purtroppo la risposta è no.
Stai dando uno spaccato deviato perché mi mostri sempre e solo dei banditi in divisa e l’unico che non lo sarebbe (Nobili) me lo fai deteriorare e corrompere dal suo servizio al punto che finisce colluso ai reati peggiori.
ACAB diventa così un’occasione persa, perché invece di scandagliare l’ambiguità dei temi importanti che solleva, pigia al massimo sul gas, ma finisce fuori strada.
Se ci sarà un seguito, spero che la serie si redima più dei suoi incorreggibili personaggi.
La cosa che ho davvero invidiato ai “colleghi” di Acab è stato il bomber di Giallini.
Ne ho preso uno su internet ma, quando è arrivato, mi stava malissimo, non sembravo neppure io.
Mi è parso l’emblema di una fiction che funziona bene come immagine sullo schermo, ma rende poca giustizia alla realtà.
___
Se vi interessa sapere qualcosa di più di me, trovate le mie pubblicazioni qui e tutto l’insieme del mio percorso qui.